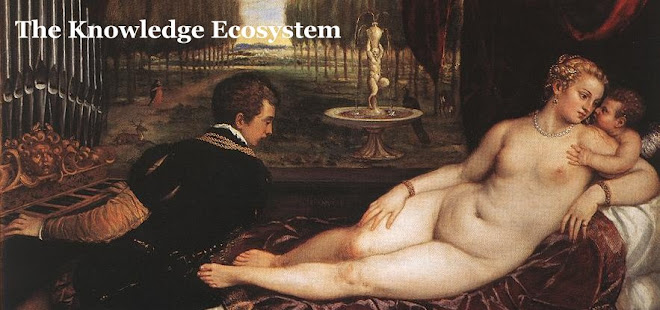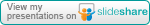Rispondo a Luca e al suo articolo sul potenziale evocativo dei modelli culturali (e della democrazia presa ad esempio particolare), rispetto al caso - solo teorico - di una comunicazione perfettamente efficace. Lo invito a leggere tutto, anche perche' in poche righe condensa molti interessantissimi spunti, e perche' si chiude con parole molte belle (perche' Luca e' un "abile comunicatore" ;-):
L'idea che la democrazia viva di una comunità consapevole che sceglie in base a informazioni metodologicamente corrette è in larga parte una bella e buona utopia. Il che non ne riduce l'importanza. Semplicemente ci insegna a pensare che il bello e il buono di quell'idea che è già diventato realtà è meno grande di quello che resta ancora da costruire.
Almeno questa consapevolezza dovrebbe diventare largamente esplicita. Se vogliamo migliorare il modo che abbiamo di informarci. Per scegliere.
Dunque, grazie ad un background culturale comune, anche comunicazioni non proprio efficaci possono portare una societa' ad agire in modo sufficientemente coordinato, e a progredire in una direzione coerente con la cultura stessa prima ancora che con le comunicazioni che vi intercorrono (cosi' ho inteso il senso della nota).
 Ma in un contesto sociale come il nostro, dove la "comunicazione" ha assunto un ruolo cruciale da molto tempo, e' andata diffondendosi una certa padronanza dell'uso dei media e dei linguaggi, ed e' grazie a questa abilita' "tecnica" che si riescono a coordinare azioni e modelli di comportamento, non in base ad una "cultura" condivisa, a meno che non si voglia parlare di "cultura della comunicazione".
Ma in un contesto sociale come il nostro, dove la "comunicazione" ha assunto un ruolo cruciale da molto tempo, e' andata diffondendosi una certa padronanza dell'uso dei media e dei linguaggi, ed e' grazie a questa abilita' "tecnica" che si riescono a coordinare azioni e modelli di comportamento, non in base ad una "cultura" condivisa, a meno che non si voglia parlare di "cultura della comunicazione".  In questo particolare contesto, gli esperti di comunicazione, o semplicmente i competenti in materia, a qualunque livello della scala del potere, sfruttano intenzionalmente la comunicazione subliminale per indirizzare il meccanismo comunicazione-azione secondo scopi predefiniti, e poco condivisi consapevolmente.
In questo particolare contesto, gli esperti di comunicazione, o semplicmente i competenti in materia, a qualunque livello della scala del potere, sfruttano intenzionalmente la comunicazione subliminale per indirizzare il meccanismo comunicazione-azione secondo scopi predefiniti, e poco condivisi consapevolmente.
Interessante sara' a questo punto, monitorare i cambiamenti prodotti dalla diffusione del "web partecipato", e la rivalutazione della "relazione" proprio come strumento di emancipazione di quella parte della societa' che era stata esclusa dalla leva del potere della "comunicazione".  Assisteremo ad uno shift dalla cultura della comunicazione alla "cultura della relazione", e nasceranno nuovi professionisti, abili nell'utilizzo di tecniche nell'ambito delle relazioni sociali.
Assisteremo ad uno shift dalla cultura della comunicazione alla "cultura della relazione", e nasceranno nuovi professionisti, abili nell'utilizzo di tecniche nell'ambito delle relazioni sociali.
Il lato B e' che si trattera' ancora di culture fondate su un unico valore piuttosto superficiale: relazionare (al posto di comunicare/apparire). Si sviluppera' - io lo temo, non lo auguro - un modello di societa' ancora poco orientato a progettualita' di prospettiva, ad elaborare e sostenere "visioni del mondo" illuminate, e a dare risposte a problematiche complesse. Non piu' "avere o essere", e nemmeno "essere o apparire", ma "essere o relazionare" sara' il prossimo dilemma dominante (tutte rivisitazioni di "essere o non essere", comunque).
Inevitabile? No. Ma dobbiamo esserne coscienti. Questa volta giochera' in positivo il fatto che la relazione e' vincente se e' 1:1, dunque non si puo' "industrializzare" come la comunicazione. Ma dobbiamo anche essere consapevoli dei costi in termini di impegno personale che la relazione richiede, proprio per questo motivo: un impegno che sottrae evidentemente energie a qualcosa di piu' sostanziale e programmatico.  Sara' quindi importante non cadere nell'errore, anche se per motivi diversi, di considerare il "relazionare" (come oggi il comunicare, l'apparire) come un valore a se' stante, se non l'unico valore, e tenere distinto il piano valoriale da quello strumentale. Visto com'e' andata negli ultimi anni, se vogliamo dimostrare che abbiamo imparato la lezione (?), educazione e stimoli appropriati sul piano culturale dovrebbero ricevere la nostra massima attenzione. Altrimenti tra cultura della comunicazione e cultura della relazione, sempre di culture fondamentalmente tecniche staremo parlando.
Sara' quindi importante non cadere nell'errore, anche se per motivi diversi, di considerare il "relazionare" (come oggi il comunicare, l'apparire) come un valore a se' stante, se non l'unico valore, e tenere distinto il piano valoriale da quello strumentale. Visto com'e' andata negli ultimi anni, se vogliamo dimostrare che abbiamo imparato la lezione (?), educazione e stimoli appropriati sul piano culturale dovrebbero ricevere la nostra massima attenzione. Altrimenti tra cultura della comunicazione e cultura della relazione, sempre di culture fondamentalmente tecniche staremo parlando.